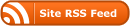di Cristina Casadei da ilsole24ore.it
Per gli atenei di tutta Europa è arrivato il momento di imprimere una forte accelerazione nella diversificazione delle entrate. Quasi i tre quarti, il 73% circa, dei budget arrivano infatti da fondi pubblici. L’Italia, però, in molti casi è al di sotto della media e «diversi atenei, soprattutto al centro nord, ricevono anche una quota di finanziamenti intorno al 67-68%», osserva il presidente della Crui, Enrico Decleva.
La quota, in media molto elevata, non sarebbe allarmante se i governi di quasi tutti i paesi non avessero annunciato tagli che Thomas Estermann, responsabile dell’unità governance, fondi e autonomia dell’Associazione europea delle università (Eua), ha analizzato e confrontato, arrivando a concludere che i tagli maggiori interessano Lituania, Italia e Grecia. Tagli tra il 5 e il 10% il Uk, Estonia, Irlanda, Lituania e Romania. Tagli fino al 5% Repubblica Ceca, Polonia, Croazia, Serbia. Nessun taglio invece in Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Olanda, Svizzera. Ungheria, Austria e Belgio scartano ipotesi di un ulteriore impegno, Francia e Germania le confermano.
Sono i primi risultati di uno studio su 150 università di 27 paesi che è stato presentato ieri a Bologna nel corso della Conferenza sulla sostenibilità finanziaria degli atenei europei. Il messaggio che arriva dal dibattito di analisti e rettori è che la sostenibilità finanziaria deriverà sempre più dalla diversificazione delle entrate. In questo alcuni paesi, come il Regno Unito, sono molto avanti, altri, come l’Italia meno. Anche se sono stati progressi. «È aumentato e si cerca di aumentare il numero di contratti e incarichi su convenzione con enti e società, sono cresciuti i rapporti di collaborazione con le fondazioni e i finanziamenti dei progetti, ma c’è ancora una forte debolezza nel fundraising», elenca Decleva. Insomma c’è attenzione all’esterno ma «non sono queste fonti di finanziamento che possono servire per attivare posizioni di assegnisti e ricercatori. I fondi diversi da quelli pubblici non possono surrogare le spese per il personale che rimangono a carico dello stato perché l’università è pubblica», osserva il presidente della Crui.Per gli atenei europei le aspettative di crescita dei fondi sono riposte in istituzioni e strumenti diversi: il 74,07% si aspetta che crescano i fondi dell’unione europea, il 67,31% la filantropia degli ex alumni, il 65% da contratti con i privati, il 62,82% dalle tasse degli studenti stranieri, il 61,25% dalla formazione continua, il 56,92% dalla filantropia delle fondazioni. In Italia, invece, le aspettative e le attese riguardano i finanziamenti pubblici e c’è molta attesa per vedere «se ci sarà una parziale riconsiderazione dell’atteggiamento dello stato verso la ricerca e l’università e quanto del taglio previsto dalla manovra del 2008 sul 2011 verrà mantenuto», dice Decleva.
Le università considerano alte le potenzialità derivanti dai fondi europei, ma sono scoraggiate dall’eccessiva complessità burocratica. Decleva conferma che «i percorsi sono complessi, però al tempo stesso molte università si sono dotate di strutture che cercano di mettere i ricercatori nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi e presentare progetti in linea con gli standard richiesti. C’è stato un miglioramento delle capacità di farsi valere dei nostri atenei».
Certo non sono nei primi 50 nei ranking internazionali, ma «sarebbe sorprendente che lo fossero rispetto alle condizioni operative delle nostre università – dice Decleva –. Quelle che sono più avanti nelle classifiche sono generaliste, hanno 60-70 mila studenti, pochi docenti. Alcune, come Harvard sono vere e proprie scuole di dottorato con poche migliaia di studenti e un numero doppio di docenti. Il livello dei finanziamenti poi fa il resto. Però anche l’Italia se cambiasse atteggiamento verso l’università potrebbe competere con i primi dei ranking internazionali».